|
|
|
|
|
SCHEDA DIDATTICA 15 |
|
LE
CORREZIONI OTTICHE |
|
L'espressione correzioni ottiche indica gli
accorgimenti utilizzati per correggere le "deformazioni
ottiche", cioè le distorsioni della vista. Lo scopo
finale è dare un’impressione di perfezione e coerenza
formale.
Le correzioni ottiche si applicano sia all'architettura
che alla scultura e pittura. I primi ad usarle in modo
sistematico sono stati i
Greci.
|
IL TEMPIO GRECO
Nell'antica
Grecia la costruzione di un tempio era regolata da
una serie di norme ricorrenti (canone)
fissate
allo scopo di dare
all'edificio un aspetto equilibrato, armonico e
oggettivo.
Due erano gli elementi fondamentali della
costruzione, la simmetria (accordo delle misure)
e l'euritmia (armonia).
Secondo lo storico romano VITRUVIO "la
composizione del tempio è una simmetria... La
simmetria nasce dalla proporzione… La proporzione è
la commisurabilità di ogni singolo membro dell’opera
e di tutti i membri nell’insieme dell’opera, per
mezzo di una determinata misura o modulo…".
Per modulo si intende una unità di misura
convenzionale che regola il rapporto tra le varie
parti che compongono un edificio e tra di esse e il
tutto; in genere è il raggio alla base del fusto
della colonna. Nel canone dell'ordine dorico
l'altezza della colonna è di 16 moduli, in quello
dell'ordine ionico è di 18 moduli e in quello del
corinzio è di 20 moduli (foto a destra).
Il canone trova un'applicazione anche nella scultura
(Doriforo
di Policleto).
Ancora
VITRUVIO definisce l'euritmia "… il
bello e grato aspetto cagionato dalla disposizione
delle membra. Si ha quando di dette membra
corrisponde l'altezza con la lunghezza e la
larghezza con la lunghezza, e insomma tutte le cose
hanno giusta proporzione". L'euritmia regola, ad
esempio, il numero e la distribuzione delle colonne:
nel
tempio periptero il numero di
colonne sui lati lunghi deve essere il doppio + 1
rispetto a quello sui lati brevi (6 / 13 nell'ordine
dorico; 8 / 17 nell'ordine ionico).
Possiamo dire che la simmetria riguarda la
quantità, interessando la corrispondenza tra le
parti in termini di misure (proporzione), mentre
l'euritmia riguarda la qualità, perché regola la
collocazione e distribuzione delle parti. Secondo lo
storico dell'arte PANOFSKY "Il
concetto di euritmia … deriva da quei 'correttivi ottici' che, aumentando o diminuendo le dimensioni,
che |
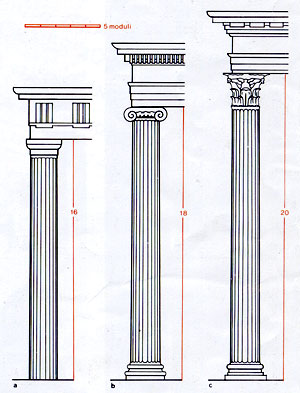 |
sarebbero corrette da un punto di vista
oggettivo, neutralizzano le alterazioni
soggettive dell'opera d'arte" (Il significato delle arti
visive, Torino 1962).
I
'correttivi
ottici' di Panofsky, cioè le
correzioni ottiche,
consistono quindi nella modifica di alcuni
dettagli della costruzione in modo da correggere
determinati effetti di curvatura delle linee o
di sproporzione (deformazioni ottiche)
dovuti a punti di vista e condizioni di luce
particolari. Le |
L'URBANISTICA
Le
correzioni ottiche sono state applicate anche nell'urbanistica,
ad esempio nella creazione di piazze monumentali in particolari
condizioni di spazio.
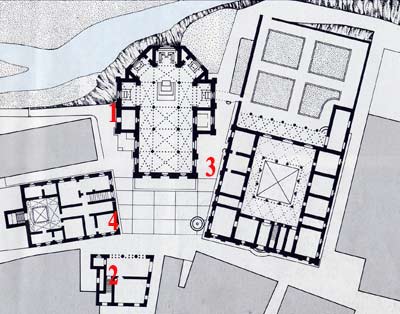 |
|
È il caso della
Piazza di Pienza,
realizzata da BERNARDO ROSSELLINO tra il 1460 e il
1464.
L’architetto progetta la piazza e gli importanti
edifici affacciati su di essa - una chiesa e tre
grandi palazzi - su richiesta di papa Pio II
Piccolomini.
Lo spazio a disposizione lo condiziona fortemente:
un'area di piccole dimensioni, stretta da un lato
dalla via principale, che segna una lieve curva, e
dal lato opposto da un dirupo.
Rossellino costruisce il Palazzo Pubblico (2)
al di là della strada e di fronte, in corrispondenza
del dirupo, il Duomo (1). Tra i due edifici
rimane uno spazio ampio poco più di 20 metri. Decide
allora di dare alla piazza non una forma
quadrata ma trapezoidale, ponendo sui lati
divergenti i Palazzi Piccolomini o Papale (3)
e Vescovile (4).
Per chi viene dalla via principale, perciò, la
prospettiva è capovolta. Sappiamo che secondo
l'ottica naturale le parallele appaiono
congiungersi all’infinito e quindi, a Pienza, i
palazzi laterali avrebbero dato l'impressione di
convergere verso il Duomo, riducendo ulteriormente
le già ridotte dimensioni della piazza e 'allontanando'
il Duomo sul fondo. Rovesciando la prospettiva, per
correggere la deformazione ottica, Rossellino
allarga illusionisticamente la piazza e 'avvicina'
il Duomo, che acquista inoltre imponenza e
monumentalità.
Una soluzione veramente geniale. |
|
 a
a |
|
|
Così geniale che
anche altri
architetti
l’applicheranno
dopo di lui: per
esempio
MICHELANGELO, nella
Piazza del Campidoglio
(dal 1536) (a), e
GIANLORENZO BERNINI, nel
Sagrato di San Pietro in
Vaticano
(dal 1656) (b),
entrambe a Roma.
|
| |
b
 |
LA SCULTURA
Le correzioni ottiche
venivano utilizzate anche
nella scultura, in
particolare per le statue
che erano collocate nella
parte alta degli edifici:
questo perché la visione da
lontano e dal
basso implica
inevitabilmente delle
deformazioni che alterano la
coerenza formale delle
immagini.
Per quel che
riguarda gli
scultori
greci
PLATONE (IV
secolo a.C.)
osserva che
coloro che
creano
"sculture
di
grandi
dimensioni"
alterano le
proporzioni
naturali delle
figure
riprodotte in
quanto se
mantenessero
"la
proporzione
oggettiva fra le
parti ... le
proporzioni
superiori
parrebbero più
piccole del
dovuto, e più
grandi quelle
inferiori,
perché noi
vediamo quelle
da maggior
distanza, queste
più da vicino";
quindi i suoi
contemporanei "calcolano
come le loro
opere
appariranno,
risulteranno
all'infermo
senso dell'uomo,
e ciò fanno
alterando,
manipolando,
inventando le
regole della
prospettiva e
altrettanti
inganni".
E famoso è un
aneddoto
riportato dal
grammatico
bizantino
GIOVANNI TZETZES
(XII secolo) a
proposito di una
gara fra gli
scultori Fidia e
Alkamenes, cui
gli ateniesi
avevano
commissionato
due statue di
Athena da porsi su un
colonnato. Vista
da vicino la Athena di Fidia
appariva
sproporzionata,
perché la testa
era troppo
grande rispetto
al corpo; ma una
volta che le due
statue erano
state messe
nella collocazione
prevista, in
alto, solo
quella fidiaca
appariva armoniosa e
anatomicamente coerente,
perché 'corretta' nelle sue
proporzioni in base alla
visione dal
basso e da
lontano. |
b
 |
Anche gli
scultori
etruschi
alteravano le
proporzioni
delle statue
disposte sul
tetto dei templi
(sculture
acroteriali)
(a), come
testimonia uno
dei capolavori
della statuaria
etrusca del VI
secolo a.C., l’Apollo
di Veio
(b), che
con altre statue
di terracotta
era collocato
sulla trave
centrale del
tetto del Tempio
del Portonaccio
a Veio. Opera dI
VULCA.
modello di
tempio etrusco -
con sculture
acroteriali -
secondo la
descrizione di
VITRUVIO |
a
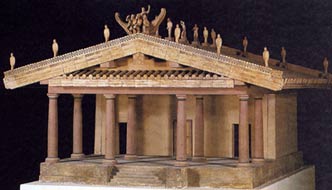 |
Nella
scultura
romana
un esempio
dell'uso di
questi
accorgimenti è
una statua
di Musa seduta
(I secolo a.C.),
di dimensioni
colossali (Roma,
Centrale
Montemartini),
che secondo gli
archeologi
doveva decorare
la scena
del Teatro di
Pompeo.
Se osserviamo la
statua
frontalmente ci
appare
sproporzionata e
sgraziata:
spalle e busto
troppo piccoli,
gambe
eccessivamente
lunghe, la mano
destra poco
visibile, solo
il piede
sinistro che
spunta dalle
pieghe della
veste; inoltre,
il panneggio del
mantello appare
piuttosto
piatto. Sembra
l'opera di uno
scultore
maldestro.
Ma se
immaginiamo la
statua nella sua
effettiva
collocazione, in
alto e secondo
una visione
angolata da
destra, allora
cambia tutto:
spalle e busto
appaiono
proporzionati,
dietro il piede
sinistro si
vedono le dita
del piede destro
che spuntano
dalla veste,
notiamo le
lunghe dita
affusolate della
mano destra,
abbandonata sul
grembo; e
rimaniamo
incantati dalla
resa raffinata e
molto
chiaroscurata
del panneggio
sul fianco
sinistro.
Anche in
epoca
rinascimentale,
come nella
scultura antica,
molti artisti
applicano le
correzioni
ottiche.
Un esempio è la
statua di
San Giovanni
evangelista
scolpita da
DONATELLO tra
1409 e 1411; era
destinata a
decorare una
nicchia,
sopraelevata,
sulla facciata
mai realizzata
del Duomo di
Santa Maria del
Fiore a Firenze.
Vista
frontalmente
è decisamente
sproporzionata,
col busto troppo
lungo, le spalle
cascanti e le
gambe corte,
coperte da un
panneggio
eccessivamente
frammentato. Ma
nella visione
dal basso le
proporzioni
diventano
naturali, il
busto si
accorcia, il
panneggio si
dispone in ampie
pieghe, il volto
trasmette
energia e
acquistano
importanza le
mani, in
particolare
quella poggiata
sul Vangelo: la
figura appare
quieta e
solenne, ma
anche potente e
animata da
spirito
visionario. |
 |
|
 |
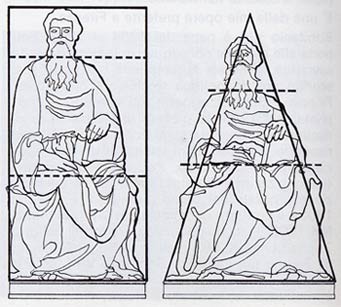 |
Statua di Musa
La statua e lo
schema del San
Giovanni
evangelista (in
C. SEYMOUR,
Sculpture in
Italy
(1400-1500),
Penguin 1966) |
|
LA PITTURA
Correzioni ottiche erano
utilizzate anche dai
pittori, in particolare
negli
affreschi delle volte, delle cupole
e nella parte superiore
delle pareti, per evitare
che le immagini, poste a
molti metri di distanza
rispetto allo spettatore,
apparissero deformate o
fossero identificabili con
difficoltà.
Un esempio?
Il
Giudizio Universale nella
Cappella Sistina,
dipinto da Michelangelo tra
1536 e 1541, è di grandi
dimensioni (m
13,7 x 12,2
) e impone una visione
dal basso, sempre più
scorciata a mano a mano che
ci si avvicina alla parete
su cui è affrescato, opposta
a quella d'ingresso alla
cappella.
Il pittore è intervenuto in
due modi. Prima ha foderato
la parete da dipingere con
un muro in mattoni
leggermente inclinato (circa
26 centimetri) verso l'alto;
poi ha realizzato le quasi
400 figure in modo che le
loro proporzioni aumentino
in relazione alla loro
collocazione nell'affresco
(in basso, al centro o in
alto), variandone l'altezza
da 1,55 a 2,50 metri.
Con questi accorgimenti, che
correggono la prospettiva
naturale, le possenti figure
appaiono di grandezza
omogenea e tutte ben
visibili, anche da un punto
di osservazione molto
ravvicinato.
[sulla censura delle
immagini del Giudizio,
click]
|
 |
|
|
|
|
(Giulia Grassi,
ottobre-dicembre 2009) |
|
|
|
|
|