|
|
|
|
|
SCHEDA DIDATTICA 4 |
|
LA
STATUARIA |
|
PERCEZIONE DI UNA SCULTURA A TUTTO
TONDO
Una scultura a
tutto tondo (statua o gruppo statuario) viene percepita in
modo diverso da un rilievo scolpito.
Il rilievo
scolpito impone una
visione
frontale e quindi la sua
osservazione è analoga a quella di
un’opera pittorica (supporto bidimensionale).
La
scultura a tutto
tondo, invece, è un
volume isolato nello
spazio e quindi la sua percezione varia in relazione al punto
di vista dell’osservatore, che può "vedere" effettivamente
solo la porzione inquadrata dal suo
sguardo. |
Ci sono
statue che si apprezzano pienamente solo frontalmente, nel senso che
è la visione frontale che ci fa comprendere chiaramente il
soggetto rappresentato e l’azione che compie.
È il caso del
Discobolo di
Mirone (460-450 a.C. circa). Solo di fronte appare
evidente che si tratta di un atleta che sta per lanciare il
disco, e si colgono bene la tensione e la concentrazione
che precedono il lancio. Solo di fronte percepiamo il senso di
'movimento bloccato' dell'atleta, come se l'istante tra il
sollevamento del braccio in cui si accumula la forza
necessaria e lo slancio del medesimo che proietta il disco
venga fermato, fissato in
un equilibrio sospeso ed eterno
(secondo linee-forza curve che si sovrappongono e si
bilanciano).
La visione frontale
riassume tutte le altre, come se la
statua
|
  |
Altre statue, invece, non hanno un punto
di vista privilegiato ma sono fatte per girarci
intorno.
È il caso
del Ratto delle
Sabine del Giambologna
(1583). Ogni punto di vista propone uno scorcio diverso,
concluso in sé ma parziale, cosicché per cogliere la
complessità dell’opera è 'necessario' girare intorno ad
essa.
Il movimento dell'osservatore è del resto 'imposto'
dallo stesso scultore, che ha rappresentato i tre corpi (due
uomini e una donna) lungo linee-forza a "S", che imitano il
ritmo spiraliforme del serpente, dette per questo figure
serpentinate (che sono state
utilizzate in modo eccezionale da Michelangelo
Buonarroti). Queste linee
suggeriscono un ritmo avvolgente e saliente, e imprimono un
grande dinamismo alla composizione e un effetto di naturalezza
e scioltezza.
La scultura si presenta come una
forma
aperta nello
spazio.
|
|
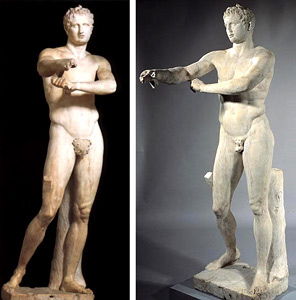 |
|
'APOXYÒMENOS' DI
LISIPPO
Lisippo di Sicione, scultore prediletto di
Alessandro Magno, è l'artista che rinnova il classico canone
di Policleto (esemplificato dalla statua del
Doriforo)
e propone un nuovo modo di rappresentare la figura umana.
Viene infatti considerato l'anticipatore della scultura
ellenistica.
La statua che esprime al meglio
queste novità è l'Apoxyòmenos (Αποξyόμενος, 'colui che
si deterge'), realizzato in
bronzo intorno al
320 a.C. e noto
in particolare da una copia romana in marmo (ai Musei
Vaticani). Rispetto al Doriforo le differenze sono
notevoli.
L'atleta non è rappresentato nella fase 'eroica'
dell'attività agonistica (mentre gareggia o trionfante dopo la
vittoria) ma in un gesto assolutamente banale, come quello del
detergersi dopo la gara, gesto che è proprio di chi ha vinto
come di chi ha perso: con uno strigile, uno strumento
in metallo, si toglie il sudore, la polvere e l'olio con cui
si era unto il corpo prima di confrontarsi nei
giochi.
Lisippo, poi, abbandona il canone proporzionale
policleteo, matematico e razionale, basato sul
principio dell'analoghìa / simmetria delle parti del
corpo. La testa è più piccola, il corpo è più snello e meno
possente cosicché la figura 'appare' più alta: l'euritmìa si sostituisce alla
simmetria.
Diversa è anche la ponderazione. Nel Doriforo il
rapporto incrociato tra arti inferiori e arti |
Doriforo di
Policleto
 |
arti superiori
(chiasmo) dava alla figura una stabilità assoluta.
Nell'Apoxyòmenos c'è una contrapposizione (antitesi):
sono 'portanti' sia la gamba che il braccio sinistro (la prima
sostiene il peso del corpo, il secondo compie l'azione di
muovere lo strigile lungo il braccio opposto); all'inverso
sono 'liberi' sia la gamba che il braccio destro (la prima è
molto arretrata e ha uno scarto deciso verso l'esterno, il
secondo subisce l'azione dello strigile). All'equilibrio
statico se ne sostituisce uno dinamico.
La figura acquista
una elasticità nuova, e un senso di interno
dinamismo, che sono anche rafforzarti dal
protendersi in avanti delle braccia, un gesto in cui
qualcuno ha visto 'la conquista della terza
dimensione' nella statuaria. Il braccio destro
disteso in avanti e quello sinistro |
piegato, che celano
in parte il busto, producono un
gioco di luci e di ombre nuovo, che varia con il variare del
punto di vista dello spettatore, il quale tende
automaticamente a spostarsi di lato per cogliere l'azione da
un'altra angolazione. Al
punto
di vista unico, frontale, della statuaria classica, si
sostituisce una pluralità di punti di vista, cosicché la
figura non appare mai la stessa.
Lisippo affermava di voler
rappresentare gli uomini "come appaiono all'occhio", mutevoli
a seconda della luce e della visuale, nel variare continuo
della realtà. L'idealizzazione classica viene completamente
superata.
Volto dell'Apoxyòmenos |

|
LISIPPO E GLI ALTRI
Lisippo è stato uno scultore molto
prolifico: gli scrittori antichi gli attribuivano circa
millecinquecento opere. L'influsso della sua scultura si
può cogliere in artisti vissuti millenni dopo di lui.
Alcuni insospettabili, come
Caravaggio. Altri più ovvi. Tra questi
ultimi, e molto
sinteticamente: Canova, col suo Ercole e Lica
(entro 1815) (vedi
Un eroe
italiano), e Michelangelo, con la figura del
Battista nel Giudizio Universale della Cappella
Sistina (1536-1541).
|
|
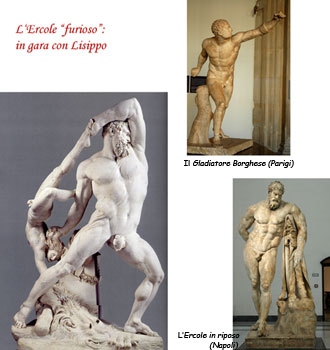
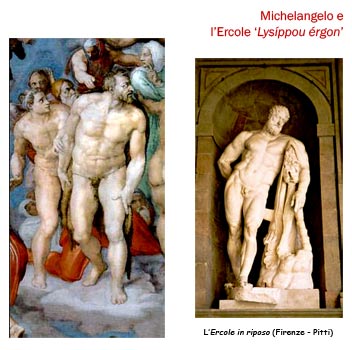 |
|
|
|
|
(Giulia Grassi, aprile 2009)
|
|
|
|
|
|