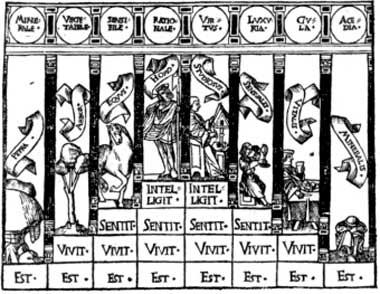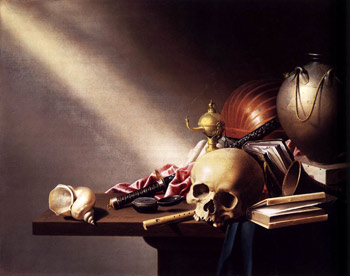del
tempo del "sacro" e della "mitologia"
che appartengono al "per sempre", come
di quello della storia "pubblica" o
privata del ritratto che prevedono
avvenimenti e date precisi: questo il
cambiamento concettuale che occorre
sottolineare, indipendentemente
dall'eventuale portato simbolico che gli
oggetti presenti possono aver contratto"
(A. Veca in 'Evaristo
Baschenis', 1997).
L'Italia e
l'Europa del
Nord si
contendono il
primato delle
origini della
natura morta, ma
i critici non
sono ancora
riusciti a
stabilire in
modo
inequivocabile a
chi
spettino realmente.
I sostenitori
della linea 'italiana' mettono in
evidenza che già nel mondo antico
esisteva una produzione di nature morte
e che in epoca rinascimentale c'è non
solo una ripresa della tradizione
artistica antica ma anche un nuovo
impulso all'indagine empirica della
natura, e alla sua rappresentazione; si
tratterebbe quindi di un rinnovato
omaggio alla classicità. I
sostenitori della
linea 'nordica'
puntano su fattori socio-culturali:
l'assenza di una tradizione
accademica di forte impianto classicista
(per cui è nobile solo la pittura di
storia); la condanna protestante delle
immagini di culto, che favorisce la
diffusione di soggetti non religiosi, di
contenuto profano; il ruolo predominante
assunto dalla borghesia mercantile, che
vede nella raffigurazione delle 'merci',
che sono alla base del suo successo, la
celebrazione del suo nuovo status
e della sua ricchezza (sono i medesimi
argomenti usati per spiegare
l'affermazione anche della pittura di
paesaggio e della scena di genere);
l'amplissima diffusione del genere
(centri di produzione, artisti
specializzati) cui farebbe riscontro il
carattere episodico del fenomeno in
Italia.
C'è anche una
interpretazione di mediazione, di chi
rileva che
"nel corso
degli anni le
due posizioni si
sono dimostrate
parimenti valide
e attendibili,
ciò ... sta a
dimostrare che
questo genere
non ebbe una
sola origine, ma
nacque in
situazioni e
ambienti diversi
con forme e e
apporti la cui
varietà ne
arricchisce
grandemente il
significato"
(M. Gregori in
'La natura morta
al tempo di
Caravaggio',
1995). E visto che nel Cinquecento "i
maestri più attenti al dato 'naturale'
sono soprattutto i pittori attivi nelle
Fiandre (in particolare ad Anversa) e in
Italia settentrionale. Queste due
grandi aree - peraltro in reciproco e
intenso contatto - si dividono il
'primato' nella nascita della natura
morta" (La
natura morta italiana, 2003).
Poiché l'argomento è molto vasto, qui se
ne propone una sintetica e ridotta
disamina (escludendo gli ultimi due
secoli).
● IL MONDO
ANTICO: XENIA E
ASAROTOS OIKOS
L'arte antica ha
conosciuto un genere pittorico
assimilabile alla natura morta moderna:
lo sappiamo sia dalle fonti scritte sia
dalle pitture parietali di Pompei e
dell'area vesuviana in generale
(ritenute dagli studiosi riproduzioni di
pitture su tavola).
Queste rappresentazioni erano chiamate
xenia:
si usava cioè lo stesso termine che
indicava i 'doni ospitali', vale
a dire i cibi freschi (frutta, verdure,
uova, formaggi...) che gli ospiti
trovavano nelle proprie stanze come dono
da parte del padrone di casa (Vitruvio, seconda metà del I secolo
a.C.). Fondamentale è la
testimonianza di Filostrato
il Vecchio (III secolo),
autore dell'opera
Immagini
(Εικόνες)
in cui c'è la descrizione della
pinacoteca di una
villa a Napoli (Neapolis).
Tra i quadri descritti ci sono due
xenia, raffiguranti l'uno della
frutta (fichi, pere, ciliege), noci, uva
con miele, formaggi e brocche di latte,
l'altro della cacciagione e vari tipi di
pane e di frutta (compresi fichi e
castagne), con l'interessante insistenza
sull'illusionismo delle
rappresentazioni (Perché non prendi
questi frutti che sembrano fuoriuscire dai due cesti? Non sai che se
aspetti anche soltanto un poco non li troverai più come sono ora, con la
loro trina di rugiada?).
|